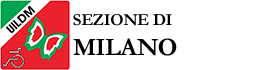La figlia di Stephen Hawking Lucy riporta, tra gli altri ricordi legati alla figura del padre, il celebre fisico recentemente scomparso, anche questo speciale incitamento. (R.R.)
«In casa si parlava sempre di scienza, ma io pensavo che fosse normale, perché ero una bambina e quella era tutta la mia esperienza di vita. All’epoca era più strano che mio padre andasse in giro con la sedia a rotelle e continuasse a viaggiare e lavorare nonostante la sua disabilità. Solo da adulta ho capito quanto gli costasse». Lucy Hawking, 48 anni, è cresciuta con un padre ingombrante, Stephen Hawking, scomparso lo scorso 14 marzo a 76 anni: il più famoso scienziato del suo tempo e una persona che per oltre mezzo secolo ha dovuto combattere con le conseguenze di una malattia terminale, la sclerosi laterale amiotrofica. Oggi Lucy si dedica a diffondere la sua eredità intellettuale e in questi giorni sta seguendo l’uscita del libro postumo di suo padre Le mie risposte alle grandi domande (Rizzoli, nelle librerie da ieri) tra Londra e Cambridge.
Era complicato farvi da padre nella sua situazione?
«Lo era. Da bambina non ero in grado di apprezzare la grandezza del suo coraggio e della sua sofferenza. Non sono riuscita a farmene una ragione fino a quando non sono diventata adulta. Era mio padre e quindi forse alcune cose che erano ovvie per gli altri non lo erano per me».
Cosa facevate insieme?
«Mi piaceva disegnare e mettere in scena spettacoli a cui la mia famiglia doveva fare da pubblico. Mio padre lo trovava molto divertente. In seguito a volte andavamo insieme a teatro. In generale facevamo le cose che fanno tutte le famiglie, ma poi andavamo all’osservatorio a guardare le stelle con il telescopio. Nel 1984 mi ha portata con lui a Mosca, dove era stato invitato da dei fisici russi: non è capitato a tutti di visitare l’Unione Sovietica da adolescente».
Il grande pubblico ha sempre sentito parlare suo padre con un sintetizzatore: lei si ricorda la sua voce?
«Sì, me la ricordo!». Nel suo tono si sente per un momento una commozione profonda, poi spiega: «Avevo 14 anni quando ha smesso di parlare. Io e mio fratello più grande, Robert, riuscivamo ancora a capirlo, ma per gli altri era diventato troppo difficile. Il sintetizzatore gli ha ridato chiarezza per tutti».
Siete vissuti sapendo di poterlo perdere: vi ha cambiato?
«Familiari e amici delle persone con una malattia terminale condividono la stessa esperienza: vivi nel presente, e trovi difficile fare piani a lungo termine, non dici “nei prossimi tre anni...”, programmi sul breve periodo».
Questo ha influenzato anche la ricerca di suo padre?
«Ha focalizzato la sua mente perché era determinato a fare qualcosa della sua vita. Ha avuto un’esistenza straordinariamente lunga nella sua condizione, ma non lo sapeva: sarebbe potuto morire in ogni istante. E ha cercato di tirar fuori il meglio da tutto».
Pensa che la sua eredità più importante sia scientifica o umana?
«Nel suo caso non si possono separare, sono l’una parte dell’altra. Ha fatto scoperte innovative per la profondità delle domande che ha posto, l’originalità delle sue intuizioni e la creatività del suo pensiero. Ma è stato importante anche perché riteneva fondamentale comunicarle in un linguaggio accessibile alle persone comuni affinché capissero che cosa significavano per la loro vita».
Nel libro appena uscito parla della possibilità di creare una razza di «superumani» grazie all’ingegneria genetica: lo preoccupava?
«Come scienziato, come persona disabile e fautore convinto della medicina scientifica accoglieva con favore questi sviluppi tecnologici. Ma diceva anche che non si può guardare solo ai benefici delle nuove tecnologie. Bisogna anche considerare quali sono i rischi».
Vale anche per l’intelligenza artificiale?
«Sì. Per questo chiedeva di istituire regole etiche e termini di condotta in cui svilupparla. L’intelligenza artificiale è uno strumento senza eguali nella storia dell’umanità, perché può superarci nelle cose che è in grado di fare. Per questo riteneva fondamentale assicurarci che i suoi obiettivi siano in linea con quelli dell’umanità».
La cosa più importante che ha insegnato a lei qual è?
«Non mollare mai. Diceva sempre: se ti trovi in un buco nero, non arrenderti, c’è sempre un modo per uscirne. Lui lo ha fatto fino all’ultimo, con grazia e senso dell’umorismo».
(Fonte: Corriere della Sera – Art. di Elena Tebano)